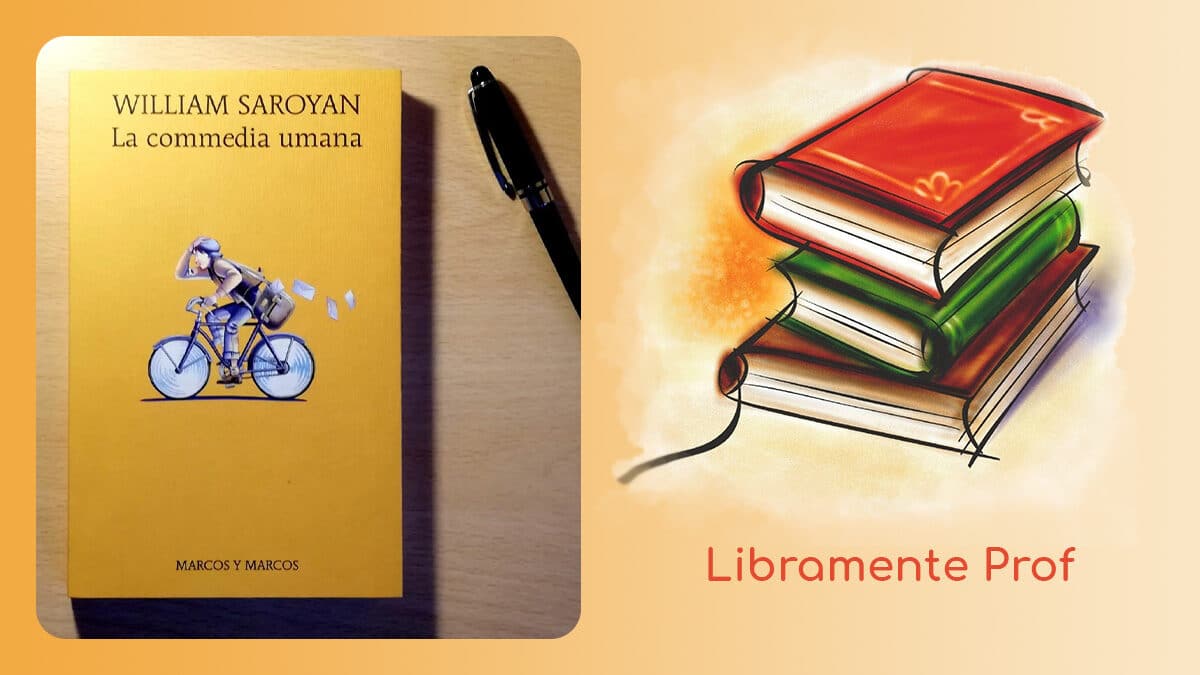
William Saroyan nacque in California (USA) nel 1908 da una famiglia di origine armena, sfuggita ai massacri dei Turchi ed emigrata negli Stati Uniti. Quando il padre morì, William fu affidato ad un orfanatrofio, dove soffrì molto per i pregiudizi razziali dei compagni. In seguito, trovò lavoro in un allevamento di galline, vendette giornali per la strada e fece il fattorino del telegrafo.
Nonostante le difficili condizioni in cui viveva, riuscì a coltivare la sua passione per la scrittura e con la prima raccolta di racconti ottenne un grandissimo successo, in America e in Europa. Lavorò quindi a Hollywood come sceneggiatore di film, divenne amico di attori famosi come Charlie Chaplin e Greta Garbo, fece vita mondana e venne considerato uno dei più grandi scrittori americani. Scrisse romanzi, racconti, testi teatrali e sceneggiature, tra cui LA COMMEDIA UMANA.
La commedia umana
di William Saroyan
4 su 514,00 €Il prezzo originale era: 14,00 €.13,30 €Il prezzo attuale è: 13,30 €.
Purtroppo, dopo la Seconda guerra mondiale, incominciò il suo declino, dovuto anche al suo carattere impossibile, sempre in contrasto con tutti: divorziò dalla moglie, fu abbandonato dai due figli, si rovinò con il gioco d’azzardo e morì quasi dimenticato nel 1991.
Il romanzo LA COMMEDIA UMANA fu pubblicato nel 1942 e narra la vita di Homer Macauley, il protagonista di quattordici anni, la cui esistenza rispecchia l’autobiografia dell’autore. Anche Homer è di origine armena e ha da poco perso il padre, frequenta il liceo e, per aiutare la famiglia, fa il fattorino del telegrafo.
È un ragazzo sensibile, costretto a compiere sacrifici, angosciato dalle ingiustizie del mondo, ma, a differenza di tanti suoi coetanei, invece di reagire con rabbia, sviluppa una grande capacità di riflettere sui fatti della vita e di comprendere l’animo umano.
Il personaggio di Homer ha aiutato a crescere generazioni di ragazzi perché è un esempio di come un adolescente, pur vivendo tra mille difficoltà, possa nutrire grandi ideali e progettare un futuro positivo.
LA COMMEDIA UMANA può senz’altro essere definito un “romanzo di formazione”, un tipo di testo in cui il lettore segue la crescita e l’evoluzione del protagonista, che di solito è un ragazzo o un bambino. Il personaggio matura affrontando pericoli, ostacoli e avversità, spesso determinati dalle vicende storiche o dalla società in cui vive.
L’ elemento essenziale è il confronto del giovane protagonista con la vita, spesso deludente o dolorosa.
Il finale della vicenda può essere positivo e lieto o drammatico: ciò che conta è che il protagonista abbia imparato dalla propria esperienza o dai propri errori.
Spesso l’ambientazione e la cornice delle vicende sono di carattere storico: ci sono personaggi realmente esistiti e fatti realmente accaduti.
I romanzi di formazione hanno come destinatari gli adolescenti che vivono nell’età in cui, lasciata la sicurezza dell’infanzia, devono costruire la loro identità. Sono gli anni in cui mente e corpo sono soggetti a molti cambiamenti, in cui i ragazzi sono impegnati a capire il mondo in cui vivono, a immaginare la società del futuro e il ruolo che in essa vorrebbero avere.
Per costruire la loro identità, i giovani devono confrontarsi sia con i propri familiari sia con altri coetanei e adulti: a volte il confronto diventa conflitto, delusione, sfiducia, smarrimento.
Attraverso le vicende dei protagonisti dei romanzi classici di formazione, gli adolescenti imparano che il conflitto è costruttivo, che è necessario mettersi in gioco per valorizzare le proprie capacità e conquistare un’autonomia di pensiero.
LA COMMEDIA UMANA ha fatto anche conoscere la difficile situazione degli Armeni, massacrati dai Turchi tra il 1894 e il 1920. L’Armenia è uno Stato ai confini con la Turchia e l’Iran. Dal 1991 è una repubblica indipendente. Per la sua posizione di frontiera e per la sua religione cristiana, la popolazione ha conosciuto innumerevoli occupazioni e persecuzioni. Oggi solo 3,5 milioni di Armeni vivono in Armenia e circa 7 milioni nel resto del mondo.




