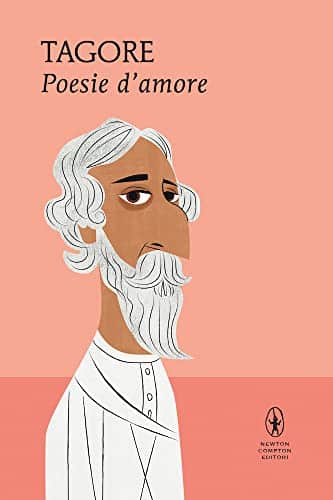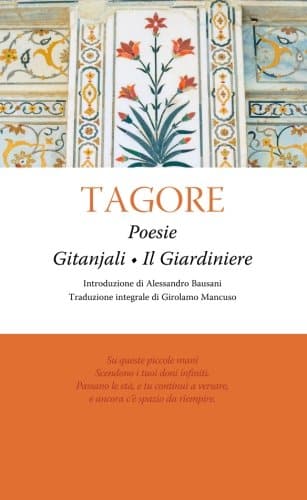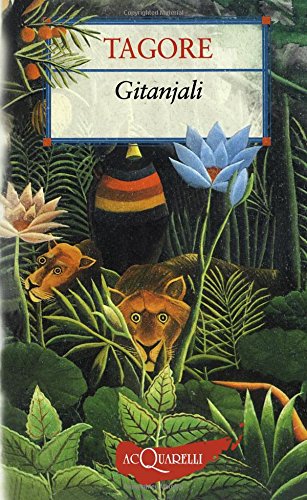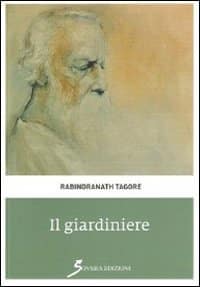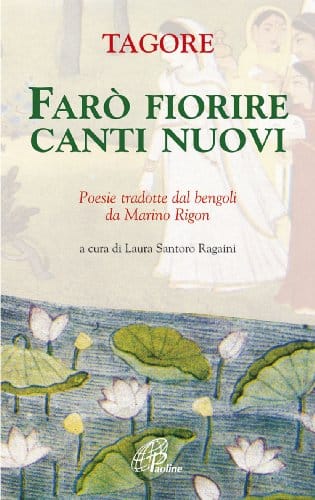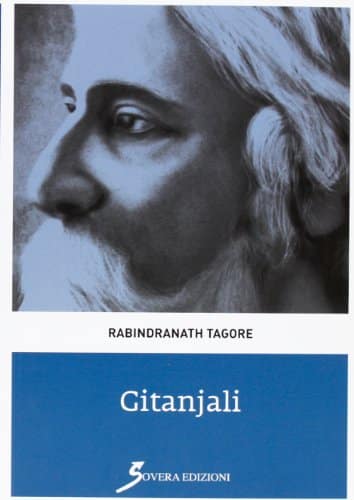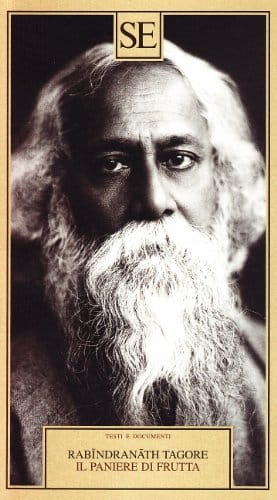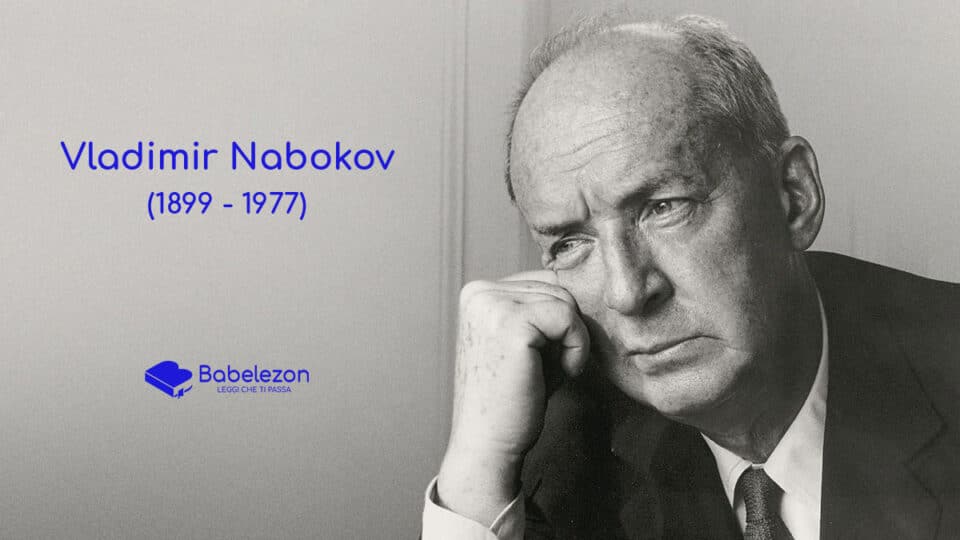La ricerca del giorno su #babelezon
7 agosto:  Rabindranath Tagore
Rabindranath Tagore 
Conosciuto talvolta anche come Gurudev, che rappresenta l’anglicizzazione del suo nome Rabíndranáth Thákhur, è stato un eminente poeta, drammaturgo, scrittore e filosofo bengalese.
Il mondo occidentale lo premia col Premio Nobel per la letteratura nel 1913,
«Per la profonda sensibilità, la freschezza e la bellezza dei versi con i quali, con consumata capacità, ha reso il proprio pensiero poetico, espresso in inglese con parole proprie, parte della letteratura occidentale.»
Fu il primo Nobel letterario non occidentale nella storia del premio. L’Università di Calcutta nello stesso anno gli conferisce la laurea honoris causa.
Nato il 7 maggio 1861 a Calcutta, India, in una famiglia nobiliare e abbiente con radici culturali e spirituali profonde.
Fin da giovane, ha coltivato lo studio del bengali e dell’inglese all’interno delle mura domestiche. Già dall’infanzia ha letto i poeti bengalesi e ha iniziato a comporre le sue prime poesie all’età di otto anni. Con il passare degli anni, la sua passione per la scrittura e la poesia ha continuato a crescere.
Tagore possedeva un’incredibile creatività artistica, che si estendeva alla musica, alla danza e alla pittura. Ha composto liriche che ha accompagnato con la musica, traducendole anche in inglese, e ha realizzato dipinti che hanno ottenuto riconoscimento anche in Occidente attraverso esposizioni organizzate appositamente. Le molteplici attività artistiche di Tagore, che includevano la scrittura di poesie, la composizione musicale, la scrittura, il teatro e la pittura, unitamente alla sua visione filosofico-religiosa personale, gli hanno garantito fama e apprezzamento in tutto il mondo.
Nel 1877, su decisione di suo padre Debendranath Thákhur, noto riformatore indù e mistico, Rabindranath Tagore è inviato nel Regno Unito per studiare legge e prepararsi a diventare avvocato. Durante il suo soggiorno in Inghilterra, il futuro poeta decide di anglicizzare il proprio nome. In questi tre anni di permanenza europea, ha l’opportunità di immergersi nella cultura occidentale e apprezzarla. Nel 1880, su richiamo del padre, torna in India.
Tagore torna dal Regno Unito convinto che gli inglesi possano “proteggere adeguatamente un’India bisognosa di protezione” e decide di dedicarsi all’amministrazione delle sue proprietà terriere e alla sua arte.
A differenza dell’approccio di Gandhi, che guidò il nazionalismo indiano attraverso la disobbedienza civile fino all’espulsione degli inglesi, Tagore perseguì l’obiettivo di armonizzare e integrare le diverse culture presenti in India. Tagore vedeva questa missione come impegnativa, ma trovava ispirazione nell’esempio del nonno, che nel 1928 fondò il “Sodalizio dei credenti in Dio”, unendo il monoteismo cristiano e il politeismo induista. Per un lungo periodo, Tagore viaggiò tra Oriente e Occidente, tenendo numerose conferenze per diffondere la propria filosofia.
Nel 1901, Rabindranath Tagore fondò a Bolpur, vicino a Calcutta, un luogo che chiamò Santiniketan, che in lingua indiana significa “asilo di pace”. Qui realizzò concretamente i suoi ideali pedagogici: nella sua scuola, gli studenti vivevano in totale libertà, in stretto contatto con la natura. Le lezioni si svolgevano all’aperto, seguendo l’antica usanza indiana. Tagore stesso teneva conferenze di natura filosofica e religiosa nella scuola, che si basava sugli antichi principi dello Ashram, un santuario nella foresta. L’obiettivo era quello di creare uno spazio in cui le persone potessero riunirsi per il fine supremo della vita, in armonia con la natura, dove la vita non fosse solo contemplativa ma anche attiva.
Il pensiero teologico alla base di tutta l’opera artistico-religiosa di Tagore trova espressione soprattutto nel suo lavoro “Sadhana“, una raccolta di conferenze tenute nella sua scuola di Santiniketan. Questo pensiero si basa su un panteismo mistico che affonda le sue radici nelle Upanishad, sebbene sia aperto ad altre tradizioni culturali. A partire dalla contemplazione della natura, Tagore vedeva in ogni sua manifestazione la presenza immutabile di Dio, sottolineando l’identità tra l’assoluto e il particolare, tra l’essenza di ogni individuo e quella dell’universo. L’invito a cercare il significato dell’esistenza attraverso la riconciliazione con l’universale e con l’essere supremo è un tema fondamentale nella filosofia indiana, e in questo contesto, Tagore si è affermato come uno dei grandi maestri del XX secolo.
Attraverso le sue liriche, così come nella sua esistenza, Tagore trasmette la sua intensa passione, che spazia anche nell’ambito erotico, insieme alla profonda ricerca di armonia e bellezza. Questa ricerca si manifesta nonostante le sfide incontrate, inclusa la sofferenza causata dalla perdita di numerosi cari.
Nel vasto corpus letterario del poeta indiano, emerge anche l’autobiografia intitolata “Ricordi della mia vita“, pubblicata nel 1912.”
Raccolta libri dello scrittore bengalese Rabindranath Tagore su Babelezon:
Gitanjali. Con testo Bengalese a fronte
di Rabindranath Tagore
16,00 €Il prezzo originale era: 16,00 €.15,20 €Il prezzo attuale è: 15,20 €.Parole d’amore
di Rabindranath Tagore
12,00 €Il prezzo originale era: 12,00 €.10,26 €Il prezzo attuale è: 10,26 €.Poesie d’amore (I)
di Rabindranath Tagore
3,90 €Il prezzo originale era: 3,90 €.3,70 €Il prezzo attuale è: 3,70 €.Il canto della vita
di Rabindranath Tagore
14,00 €Il prezzo originale era: 14,00 €.13,29 €Il prezzo attuale è: 13,29 €.La casa e il mondo
di Rabindranath Tagore
18,00 €Il prezzo originale era: 18,00 €.17,10 €Il prezzo attuale è: 17,10 €.La poesia della natura
di Rabindranath Tagore
12,00 €Il prezzo originale era: 12,00 €.11,40 €Il prezzo attuale è: 11,40 €.Hai colorato i miei pensieri e i miei sogni. Poesie per giovani innamorati. Nuova ediz.
di Rabindranath Tagore
9,00 €Il prezzo originale era: 9,00 €.8,55 €Il prezzo attuale è: 8,55 €.Farò fiorire canti nuovi
di Rabindranath Tagore
9,30 €Il prezzo originale era: 9,30 €.7,90 €Il prezzo attuale è: 7,90 €.La civiltà occidentale e l’India
di Rabindranath Tagore
16,00 €Il prezzo originale era: 16,00 €.15,19 €Il prezzo attuale è: 15,19 €.Il paniere di frutta (I)
di Rabindranath Tagore
12,00 €Il prezzo originale era: 12,00 €.11,40 €Il prezzo attuale è: 11,40 €.Fiabe magiche. Ediz. a colori
di Rabindranath Tagore
16,90 €Il prezzo originale era: 16,90 €.16,05 €Il prezzo attuale è: 16,05 €.Poesie d’amore (II)
di Rabindranath Tagore
7,00 €Il prezzo originale era: 7,00 €.6,30 €Il prezzo attuale è: 6,30 €.